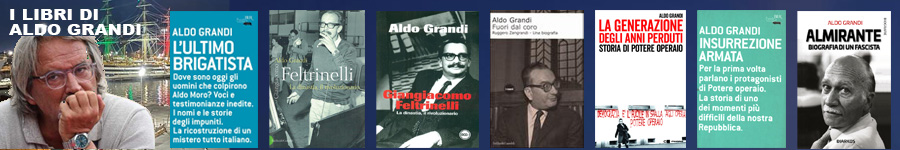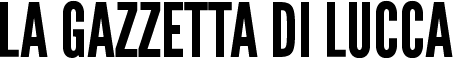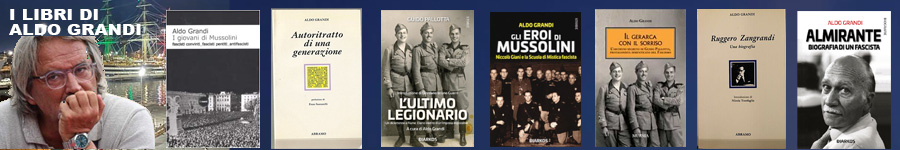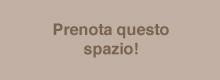Luciano Bianciardi (Grosseto, 1922- Milano, 1971) è stato uno degli scrittori più lucidi e abrasivi del nostro secondo Novecento letterario. Narratore insieme ingenuo e disincantato, nei suoi libri ha raccontato l’inabitabilità del proprio tempo, per molti tratti assai simile al nostro. L’aurorale società dei consumi gli stava stretta e, allora, il letterato maremmano era solito rifugiarsi nel passato e nella vicenda fondativa della nostra storia nazionale, il Risorgimento e, segnatamente, quello in camicia rossa, quello della spedizione siciliana guidata dall’Eroe dei due mondi. Di Risorgimento, Bianciardi ne sapeva e ne scriveva…E c’era una questione che tornava spesso nelle sue pagine: il dispiacere perché le imprese dei protagonisti del Risorgimento, così dense di avventure – fughe e nascondimenti, amori e tradimenti, viltà ed egoismi, assedi ed esili, sconfitte e vittorie – non fossero mai diventate una epica nazionale.
Pensate, diceva Bianciardi, se ce lo avessero avuto gli americani di Hollywood un patrimonio di storie come quello di Mazzini, Garibaldi, Pisacane, … Come quella di Antonio Mordini di Barga, la cui biografia ci appare davvero capace di comprendere in sé tante anime, tanti aspetti, tante passioni prima e anche dopo l’Unità d’Italia.
Figlio di un’illustre famiglia di Barga, conservatrice ma di sentimenti liberali, Antonio Mordini si avvicina agli ambienti mazziniano-repubblicani nei suoi anni universitari, prima a Pisa, dove si laurea in legge, poi a Firenze. Qui, alla vigilia del ’48, organizza le manifestazioni popolari che reclamano libertà e riforme. Nominato capitano della Guardia Civica toscana, partecipa da volontario alla I° guerra d’indipendenza, intrecciando la partecipazione agli eventi bellici con una forte attenzione per la politica, sempre su posizioni repubblicane intransigenti. Per questo entra in rotta di collisione con Daniele Manin, presidente del governo provvisorio di Venezia dopo la rivolta antiaustriaca del marzo ’48. In seguito alle accuse di Mordini di tiepidezza repubblicana e nella condotta della guerra, Manin fa espellere il barghigiano da Venezia. Rientrato a Firenze nell’autunno del ’48, agisce nella prospettiva di una Costituente nazionale fondata su tre parole d’ordine: guerra all’Austria; suffragio universale; unificazione d’Italia sotto un sistema repubblicano. Nei giorni confusi del governo provvisorio di Guerrazzi-Mazzoni-Montanelli costituito dopo la fuga del granduca a Gaeta, Mordini, appena trentenne, assume responsabilità di governo addirittura con due dicasteri, quello degli esteri e quello della guerra. Non idilliaci i suoi rapporti col Guerrazzi, ostile all’idea di una proclamazione della repubblica a Firenze, e a una Costituente capace di comprendere la Toscana, Roma, e Venezia.
Dopo la restaurazione del governo granducale nel ’49, Mordini, ricercato dalla polizia, è costretto alla fuga. Condannato all’ergastolo, esule tra la Francia e il Piemonte, nel corso degli anni ’50, matura a poco a poco il distacco da Mazzini e dalle sue pratiche insurrezionali. Nel marzo del ’59, alla vigilia della II guerra d’indipendenza, scrive: “Se il governo piemontese inizia la guerra al grido Viva l’unità italiana, il nostro partito deve dare la sua adesione collettiva riservando la questione della forma politica a guerra vinta.” È la posizione della Società Nazionale: Garibaldi l’aveva scelta dal 1857, Mazzini l’avversava.
Se la sua stella polare, sino a questo momento è stato Mazzini, ora Mordini si avvicina a Garibaldi: nel ’59 è con i Cacciatori delle Alpi, l’anno dopo partecipa all’impresa dei Mille, in ruoli di assoluto rilievo. Al punto che, quando Garibaldi passa sul continente, lascia in Sicilia Antonio Mordini col ruolo di prodittatore: un incarico delicatissimo che dura sino al 1 dicembre 1860, quando Vittorio Emanuele II entra a Palermo, prendendo ufficialmente possesso dell’isola.
Inizia così la seconda vita di Mordini, quella politico/istituzionale: dal 1861 al 1896 è deputato, quindi senatore dal 1896 alla scomparsa, il 14 luglio 1902. Non si pensi, però, a un lungo e placido pensionamento…
Nel 1862 viene coinvolto nella vicenda di Aspromonte che gli costa, ingiustamente, il carcere a Napoli. Poi, va ricordato, il suo tentativo di costituire il cosiddetto “terzo partito”: ovvero, una rappresentanza politica capace di attrarre gli elementi più moderati della sinistra costituzionale e i più progressisti tra gli uomini della destra, trovando convergenze sui grandi temi della politica interna e sul completamento della unità nazionale. Un raggruppamento democratico-costituzionale la cui guida viene da Mordini offerta a Garibaldi che, però, la rifiuta. Ministro dei Lavori Pubblici nel terzo governo Menabrea, come vicepresidente della Camera, il 28/XI/1871, presiede la prima seduta del Parlamento a Roma, capitale d’Italia. Ormai esponente della destra, con la rivoluzione parlamentare del 1876 si colloca all’opposizione: nel 1884 rifiuta la presidenza della Camera offertagli da Depretis e per due volte ricusa il ministero degli Esteri propostogli da Crispi.
Nel 1893, in qualità di presidente e relatore della Commissione d’inchiesta per lo scandalo della Banca Romana, non esita a denunciare il coinvolgimento di numerosi suoi antichi compagni di fede e di militanza, tra cui lo stesso Crispi.