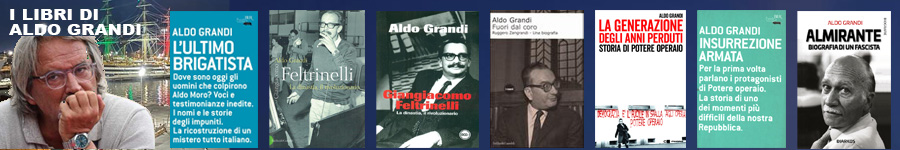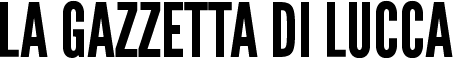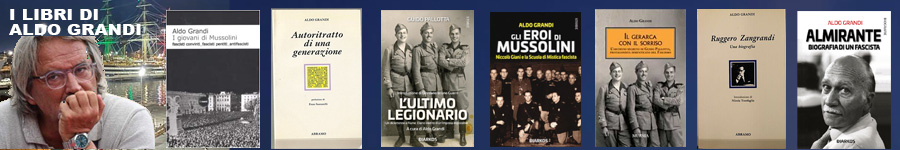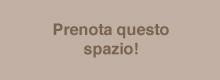Mezzo secolo fa.
Correva l'anno 1973. Procedeva a larghi passi: implacabile, attraverso un'inflazione già a due cifre che si mangiava gli aumenti salariali ottenuti attraverso faticose lotte sindacali (metalmeccanici, tessili, insegnanti…), mentre le strade e le piazze tornavano a tingersi del colore del sangue di studenti, di gente comune che pagava il prezzo di essersi trovata nel posto sbagliato nel momento meno adatto, di agenti di Ps. Pure a destra si moriva: in una vicenda tragica passata alla storia come il "rogo di Primavalle" che avrebbe trovato solo quarant'anni più tardi la sua amara conclusione. Non ci rendemmo conto, allora. che sciagurati assassini ce n'erano anche tra i compagni. Eppure il moltiplicarsi di sigle di fantomatiche organizzazioni, che, attraverso esemplari atti di violenza, aspiravano a dispensare una sedicente, contorta "giustizia popolare" avrebbe dovuto farci riflettere. Una, in particolare, conquistava con le sue imprese biliose e sanguigne le cronache dei giornali: i suoi protagonisti si facevano chiamare Brigate rosse, erano armati e usavano il sequestro di persona e il "processo proletario" come strumento di lotta politica. Li sentivamo lontani anni-luce dalla nostra idea di socialismo nutrita di democrazia diretta e decentramento, di mite umanesimo e autorganizzazione dal basso degli oppressi, di assemblee e collettivi. Gli "eroi della stella a cinque punte" lasciavano trapelare un odore di chiuso e di vecchio che non ci piaceva. Avremmo dovuto contrastarli, invece ci limitammo a ignorarli. E sbagliammo, perché la violenza che loro arrogantemente e di forza infilavano nelle nostre vite avrebbe avvelenato, chi più chi meno, un po' tutti e non si sarebbe chiusa come un rubinetto.
Intanto, in estate, il sud esplode. Nel luglio, a Napoli, in seguito a una serrata dei panificatori, scarseggia il pane che viene venduto a 1600 lire al kg al mercato nero invece delle 160-190 lire stabilite dal comitato provinciale prezzi. Seguono tre giorni di dure proteste con tanto di saccheggio dei forni, posti di blocco e barricate nei quartieri poveri della città che, un mese più tardi, è colpita da un'epidemia di colera che si allarga ad altri centri del Meridione. Sembra di essere regrediti in pieno medioevo. Una sensazione ribadita dalle fotografie del presidente della Repubblica Giovanni Leone che, in visita ai ricoverati napoletani di quell' affezione presso l'ospedale "Cardarelli", si lascia andare ad antichi gesti scaramantici (le corna!), che creano più di un motivo di perplessità nell'opinione pubblica nazionale e oltre. Ci sarebbe stato da sorridere se, alla fine della fiera, non si fossero dovuti contare trenta e più morti.
Il primo 11 settembre. El pueblo unido jamàs serà vencido.
I fatti, come è noto, si incaricarono di contraddire tale perentoria affermazione. El pueblo non solo fu vencido, ma pure pesantemente con la durezza spietata che i potenti sono soliti riservare a quanti hanno osato ribellarsi, magari anche con un certo successo iniziale, alla loro autorità. Ai poveri di quel lontano Paese latinoamericano fu inflitta una lezione da non dimenticare che parlasse, e in maniera esplicita, anche alle altre genti del "cortile di casa": non si azzardassero ad alzare la testa, altrimenti gliela avrebbe fatta abbassare il big stick nordamericano. Per piegarlo, il popolo cileno, si allearono le multinazionali del rame e i generali felloni, i reazionari, che anche in quel Paese non mancavano di sicuro, e le logiche di dominio dell'imperialismo americano. Il presidente socialista Salvador Allende, legittimamente eletto attraverso libere elezioni, muore mentre difende la sua casa, il palazzo presidenziale della Moneda, e quella di tutti i cileni. Le ultime foto lo consegnano alla storia che indossa un improbabile maglione da casa, un elmetto militare e imbraccia un fucile mitragliatore. Glielo aveva regalato Fidel Castro, sempre scettico ma lungimirante, sulla correttezza democratica degli Usa.
Dopo la Cecoslovacchia di qualche anno prima, un altro colpo durissimo all'idea dell'autodeterminazione dei popoli: chi si ostinava a crederci non poteva che sentirsi più solo e impotente. Non fu una bella esperienza quella di dover ammettere già a venticinque anni che la storia, anche la nostra, quella che vivevamo ogni giorno con una straordinaria passione civile quale non ho mai più ritrovato negli anni successivi, assomigliava "sempre più a un mucchio di macerie e di speranze distrutte, deluse e infrante che a una logica di progresso organizzata per tappe di superamento".