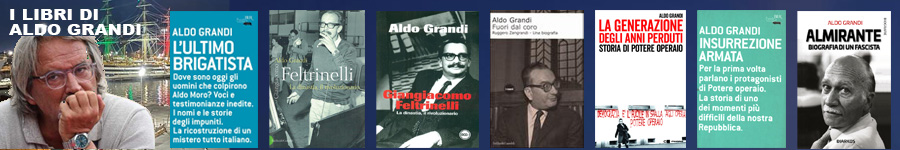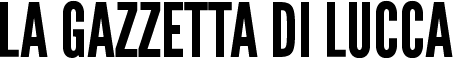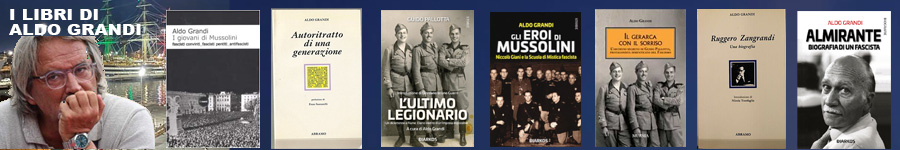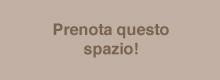Quando il nome del proprio paese non piace è sempre possibile correre ai ripari. La toponomastica italiana è fitta di casi in cui gli abitanti di comunità piccole e meno piccole non si sono sentiti rappresentati dal nome del luogo che la storia o la geografia hanno loro assegnato come ambiente di vita e di lavoro. Spesso, anzi, hanno percepito quella denominazione come poco significativa, disdicevole o addirittura offensiva. E allora l’hanno cambiata radicalmente, talora con effetti inconsapevolmente comici. Proviamo a raccontare qualche caso
Porcile e Belfiore
Nel lontano 1547 i residenti di Porcile nel territorio di Verona brigarono non poco per ottenere la sostituzione del nome del loro paese ritenuto sconveniente: ma l’istanza presentata al Consiglio dei Dodici della città veneta, l’organismo che aveva competenze in materia, non fece altro che peggiorare la situazione: il risultato fu Belfiore di Porcile, un rimedio peggiore del male che gli improvvidi abitanti furono costretti a portarsi addosso per 320 anni, fino al 1867. Finalmente, dopo la terza guerra d’indipendenza e il ritorno del Veneto all’Italia, qualcuno si accorse dell’incongruo ossimoro che gravava sui solerti cittadini di Belfiore di Porcile e pensò bene di provvedere. Oggi, il piccolo comune a oriente di Verona, 2674 abitanti, 26 metri sul livello del mare, si chiama solo Belfiore: senz’altro più poetico, ma scarsamente rispettoso delle radici originarie.
Una semplice a che mette tutto a posto
Sensibili anche gli abitanti di Sacrofano, piccolo comune a nord di Roma tra la Cassia e la Flaminia. Fino al 1928 si chiamava Scrofano e i residenti trovavano poco decoroso questo toponimo, forse perché rimandava alla scrofa, la femmina del maiale - che pure campeggia ancora ai nostri giorni nello stemma comunale - considerato, ancora una volta, animale poco nobile; oppure perché richiamava alla memoria lo scorfano, un pesce teleosteo diffuso nel Mediterraneo dall’aspetto mostruoso, provvisto di aculei collegati con ghiandole velenose e quindi di nessun valore commestibile.
Così Scrofano è diventato Sacrofano… E non è stato difficile agli intraprendenti abitanti della cittadina laziale nobilitare le proprie origini rielaborando la notizia della presenza in tempi remotissimi di un “sacrum fanum”, ovvero un sacro tempio, misterioso e mai documentato, dedicato niente meno che al dio etrusco Velta.
I toponimi maledetti
Eccessivamente somigliante a un termine interdetto e per di più in forma accrescitiva. Troppo per gli abitanti di Cazzone, simpatico e ameno paesino (non arriva oggi ai cinquemila abitanti) del Varesotto al confine con la Svizzera, per i quali non deve essere stato facile convivere col nome del luogo che aveva dato loro i natali. Così, stanchi di essere additati come indigeni di un’area designata col nome più diffuso dell’organo maschile, e per di più comunemente usato nell’accezione di sciocco, stupido, nell’ormai remoto 1895 gli autoctoni decisero di darsi l’assai più banale denominazione toponimica di Cantello, ovvero “cantuccio di terra”: certo più delicata della precedente ma, diciamoci la verità, meno simpatica ed espressiva del bonario Cazzone. Che poi, la parola proibita niente aveva a che fare con un superdimensionato membro virile, ma rimandava a una grossa cazzuola: un mestolone da sempre strumento di lavoro e orgoglio professionale di generazioni e generazioni di laboriosi muratori.
Un’identica, pudibonda, motivazione sta alla base della trasformazione del maceratese Ficano nel più anonimo e anodino Poggio San Vicino. Qui, chiamata in causa è la metafora eufemistica con cui, sin dall’antichità classica, si è soliti indicare l’organo sessuale femminile: già Aristofane usava il termine sukon per designare quella che Gustave Courbet, un maestro del realismo francese, in un suo celeberrimo dipinto, chiama l’Origine du monde. Ma nel 1927 alla vigilia dei Patti lateranensi che avrebbero riconciliato Stato e Chiesa anche il nome di un piccolissimo Comune marchigiano di appena qualche centinaio di abitanti poteva assurgere a motivo di scandalo da normalizzare assolutamente. E così fu.
Corna e fegato
Non è certo difficile immaginare le battute, non sempre lievi, gli sfottò e i sorrisetti maliziosi che, ne siamo sicuri, hanno punteggiato la vita quotidiana degli abitanti di sesso maschile di Corneto nell’alto Lazio: troppo forte l’evocazione fonetica del nome che designava quel luogo d’origine per non mettere maliziosamente in discussione l’onorabilità delle loro donne. Niente di meglio, quindi, poco meno di un secolo fa, che recuperare, con la denominazione di Tarquinia, la memoria di un’antica, potente e rispettata città.
Che bel nome, Borgorose! È tutto un profumo! E pensare che, la piccola città reatina al confine con l’Abruzzo aquilano che si fregia oggi di un appellativo così aulente, sino a poco più di mezzo secolo fa, per la sua denominazione sollecitava impressioni tutt’altro che fragranti. Si chiamava, infatti, Borgocollefegato dallo sgradevole colore rosso bruno della roccia locale. Meno male che il vicino monte Rose ha fornito lo spunto delicato per la soluzione del problema.
Caccavone
Particolarmente suscettibili anche gli abitanti dell’antico Comune di Caccavone (Is). In una delibera del 20 febbraio 1921 si legge: “poiché il nome del Comune ricorda nella prima parte una cosa che disgusta e nella seconda un accrescitivo che riempie la bocca e gli orecchi, suscitando il riso e la derisione della gente, questo viene cambiato in Vinoli secondo i prodotti tipici locali”. Ma pochi mesi più tardi, ancora insoddisfatto, il Consiglio comunale approva una nuova delibera che, fondendo la splendida posizione paesaggistica e la presenza, testimoniata da consistenti reperti archeologici, di accampamenti sanniti conia il nome di Poggio Sannita, 705 metri sul livello del mare, più o meno 2000 abitanti impegnati a smemorare il “disgustoso” grosso caccavo… Ovvero niente altro che il recipiente in rame usato dai pastori per il coagulo del latte.
Nella foto: il paese di Cantello, già Cazzone