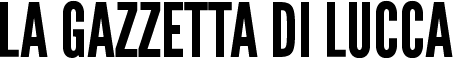Cultura
Da Picasso a Warhol: arriva a Lucca la mostra dedicata alle cover d’artista
Arriva a Lucca, con il patrocinio del Comune, la mostra Da Picasso a Warhol – Le vinyl cover dei…

Torna Real Collegio Estate: 32 serate da non perdere fra musica, teatro, poesia e spettacoli per bambini
È stata presentata mercoledì mattina alla città la nuova edizione di Real Collegio Estate, la rassegna che dal 9 luglio al 31 agosto farà del chiostro medievale di…

Puccini Marching Band, una rassegna di bande musicali animerà le strade e le piazze di Lucca
È stata presentata questa mattina nel bookshop del Puccini Museum – Casa Natale di piazza Cittadella la rassegna

Lucca Comics & Games, l'anno dei French Kiss in un periodo di guerre nel mondo
Si apre la road to Lucca Comics & Games 2025, il community event più grande dell'Occidente, che si terrà da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre. Per…

Un incontro alla Pecora Nera con Stefano Pierotti (quello della scultura fuori Porta Sant'Anna)
L'artista e sculture Stefano Pierotti, autore dell'istallazione "in divenire" che si trova sulla rotatoria fuori Porta Sant'Anna…
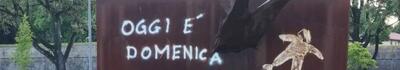
Ecco il concorso internazionale di composizione lirica da camera dedicato a Giacomo Puccini
L'Accademia Internazionale di Composizione Lirica Puccini di Lucca, in occasione del 125° anniversario della Tosca di Giacomo Puccini, è lieta di bandire il “Concorso internazionale di composizione lirica…

Lucca Historiae Fest, una terza edizione da incorniciare
Domenica si è conclusa la terza edizione del Lucca Historiae Fest, il festival organizzato…

I sistemi instabili al centro della prossima edizione di Pianeta Terra Festival: svelato il programma
Anche quest’anno Lucca si appresta a diventare teatro di una nuova edizione del Pianeta Terra Festival, evento culturale guidato da Stefano Mancuso, organizzato da Editori Laterza e sostenuto…

Festival della sintesi: geopolitica, arte e giornalismo protagonisti della prima giornata
Mercoledì 18 giugno inizia la decima edizione del Festival della sintesi che si terrà nella chiesa di Sant’Alessandro e accompagnerà il pubblico fino a sabato 21 giugno con…

Scrivere per sconfiggere il dolore
Un’antica vicinanza e un’affinità. Quasi un’alleanza quella che che ritroviamo in non pochi clinici, tra pratica medica e letteratura. Sembra quasi che per molti medici la letteratura, rappresenti…

- Scritto da Redazione
- Cultura
- Visite: 833
Settant'anni e non sentirli. Umberto Tozzi è irriducibile, come la sua musica.
Certe sue canzoni sono immortali, fissate per sempre nel firmamento della canzone d'autore italiana. Gloria, Ti amo, Si può dare di più, Gente di mare, Tu, Stella stai non sono classici, sono pietre miliari.
Il suo concerto a Castelnuovo era molto atteso dopo il rinvio per maltempo dei giorni scorsi. Stavolta le nuvole minacciose hanno deviato il loro corso, concedendo a migliaia di spettatori di godere finalmente del proprio artista. Pubblico variegato per questo ultimo appuntamento del festival "Mont'Alfonso sotto le stelle" in Fortezza: uno spaccato generazionale che la dice lunga su quanto questo autore abbia inciso nella cultura di massa del suo tempo.
Prima dell'esibizione, il sindaco Andrea Tagliasacchi ha voluto fare un doveroso applauso all'organizzazione e allo staff della PRG, ringraziando gli sponsor e tutti i volontari che hanno prestato servizio per la riuscita del festival.
Poi le luci sul palcoscenico sono calate, ed è iniziata la magia.
Un successo dietro l'altro: il cantautore torinese, accompagnato sul palco dall'affiatatissima band, ha ripercorso tutta la sua lunga carriera, costellata di brani storici che la platea non ha smesso un minuto di cantare. Per partire Notte Rosa ed Equivocando - giusto per rompere il ghiaccio - poi i telefonini si sono accesi per accompagnare la struggente Ti amo e un mare di luci ha invaso l'enorme prato.
Il colpo d'occhio: stupendo.
Quindi qualche intramontabile canzone del repertorio: da Gli innamorati a Io camminerò, quest'ultima intonata a squarciagola dai fedelissimi fans presenti. E, a questo punto, Umberto Tozzi si è seduto, il gruppo ha lasciato la scena, ed è rimasto solo lui con la sua chitarra acustica. "Ho cominciato come chitarrista autodidatta - ha raccontato al microfono - e agli inizi suonavo con gli amici sulle panchine della mia Torino. Ho avuto la fortuna di vivere in un periodo storico della musica mondiale privilegiato". E via con un medley amarcord che ha omaggiato Simon & Garfunkel (The sound of silence) e Lucio Battisti (I giardini di marzo).
Da brividi.
Si può dare di più ha dato la carica per il rush finale. Irresistibile la voglia di alzarsi in piedi e di ballare. C'è chi ha ceduto su Gente di mare, chi su Io muoio di te, chi - eroico - ha aspettato fino a Tu, poi, però, anche il più cinico si è alzato in piedi sulle note travolgenti di Stella Stai e di Gloria.
Un finale col botto per gli appuntamenti in Fortezza. Ora il festival si sposterà al Teatro Alfieri per recuperare Le Quattro Stagioni di Vivaldi, con l'Orchestra da Camera Fiorentina, e chiuderà in bellezza con l'omaggio teatrale di Stefano Accorsi a Ludovico Ariosto.
Non vediamo l'ora.
Foto di Andrea Cosimini
- Galleria:
- Scritto da Redazione
- Cultura
- Visite: 771
Perché il volo di Magda è folle? Non certo perché si è abbandonata ad un sogno d'amore; quanto perché, una volta trovato il coraggio di lanciarsi nel vuoto, ha lasciato che la paura di cadere la facesse desistere dal tentativo.
"La rondine" di Giacomo Puccini spicca il volo degli audaci, ma termina planando timidamente a terra. Se Parigi è un miraggio di passione sfrenata, la comodità di una vita agiata è uno specchietto per le allodole: dietro di essa si insinuano noia e monotonia.
L'opera lirica del maestro lucchese debutta sulle rive del lago di Massaciuccoli per il colpo di coda del festival estivo. Sotto un cielo clemente, nonostante i tuoni all'orizzonte, il dramma pucciniano ha conquistato il cuore degli spettatori che, sfidando le previsioni del tempo, si sono riversati numerosi al gran teatro all'aperto per assistere alla prima a Torre del Lago.
Favoloso il colpo d'occhio sul palco: un allestimento antico e moderno allo stesso tempo, con un vecchio pianoforte in legno posizionato in un angolo e un tavolo spartano al centro, il tutto racchiuso in una futuristica architettura dal design minimale ed astratto. Complimenti al Maggio Musicale Fiorentino e al regista Denis Krief per la scenografia. Davvero d'impatto.
Lo spettacolo si è articolato in tre atti intervallati da due pause di 25 minuti ciascuna. Un inizio dinamico e concitato, con i vari commensali impegnati ad animare la scena tramite scambi frizzanti e scherzosi: tra poeti, ricchi ereditieri, donne sognanti e cameriere in fuga, un affresco molto bohemien della borghesia di inizio novecento.
La recita parla di amori, sogni, illusioni. In una parola, parla di Parigi: la città per eccellenza di ogni autentico romantico. Al centro della storia troviamo due donne, Magda e Lisette (strepitose nell'interpretazione canora delle soprano Jacqueline Wagner e Mirjam Mesak), e i loro rispettivi amanti, l'irresistibile Ruggero e il poeta Prunier. Tra intrighi, trame segrete ed intrecci la parabola di queste due coppie registra un saliscendi di emozioni. Sotto la magistrale direzione del maestro Robert Trevino, si ballano valzer, si ride di gioia, si piange dallo sconforto e si fantasticano storie di amori impossibili e sconfinati.
Bella la scenografia del secondo atto: la struttura allestita sul palcoscenico si smonta in tre pezzi e una miriade di comparse popola la scena. L'ironia la fa da padrona, le maschere del giorno cadono ed i ruoli della società si invertono: le cameriere si camuffano da padrone, le signore da fatali seduttrici, i poeti da incalliti don giovanni e gli uomini timidi ed impacciati da coraggiosi avventurieri. La ragione fa spazio al sentimento e le rondini sognano voli pindarici dalle vette più vertiginose dell'anima.
Nel terzo ed ultimo atto, però, la location cambia: la paura sembra insinuarsi in questo fatato mondo. Del castello di sogni, rimane solo una piccola casetta bianca, semplice ed austera, dove Magda e Ruggero devono elemosinare una sopravvivenza difficile. Il volto della povertà si mostra per la prima volta alla sognatrice. Ruggero lo vince, ma Magda è troppo debole. Non resiste. Preferisce tornare alle comodità di cortigiana, rinunciando così per sempre al suo sogno d'amore. Gli unici che sembrano amarsi oltre ogni difficoltà sono il poeta e la cameriera: loro resistono alla prova della miseria perché già assuefatti dalla penuria di opportunità e risorse.
La rondine è un uccello che migra: può fare giri immensi ma, alla fine, torna sempre al proprio nido.
- Galleria: